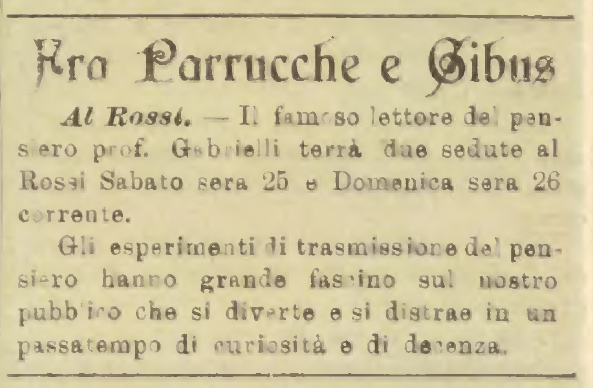Pesci gatto, tartarughe e anguille elettriche: la quarantena segreta negli Acquari della Certosa
Il “pipistrello della discordia”, i cani a passeggio, la fauna selvatica che torna in città: in queste fasi della pandemia da Covid-19 gli animali sono stati grandi protagonisti. Ma agli abitanti dell’Acquario di Calci, chiuso dall’8 marzo, qualcuno ci ha pensato?
Nella foto: La nuotata in solitaria della tartaruga Piggy
di Chiara Zucchellini
foto di Enrico Mattia Del Punta
«Il luccio è sempre stato il mio pesce preferito. È entrato in servizio poco dopo di me, sicché ci sono sempre stato dietro. L’ho chiamato Semola, come ne La Spada nella Roccia… sai, no, che c’è il luccio… Se i pesci fossero tutti come lui non avremmo problemi. È un pesce modello: non si è mai ammalato, non è cattivo, mangia tranquillamente e ci lascia fare le pulizie». A parlare è Matteo Lucarelli, uno dei due manutentori dell’Acquario di Calci. Matteo è giovane, sorridente, e quando parla di pesci gli brillano gli occhi. Come il luccio, è in servizio ormai da due anni e affianca il manutentore senior, Alessandro Pancrazi. In collegamento con noi, Paola Nicolosi, referente degli Acquari dal 2018, gli dà la stura: «Vai, Matteo, sfogati!». E così arriva il fiume di parole, un fiume pieno di pesci – è il caso di dirlo! – e ogni spunto è un colpo di pinna che porta al successivo. Per esempio, già da qui capisco che i pesci dell’Acquario: a) talvolta hanno un nome di battesimo; b) sono pieni di sorprese (io il luccio de LaSpada nella Roccia lo ricordo cattivissimo); c) a volte si ammalano; d) possono richiedere cure rocambolesche.

Ma prima di svelare la quarantena segreta fra gli acquari della Certosa, facciamo un passo indietro. L’Acquario di Calci, spiega Paola Nicolosi, è aperto dal 2008, ma è con l’ampliamento del 2016 che diventa l’acquario d’acqua dolce più grande d’Italia: 60mila litri per un centinaio di specie da tutti i continenti. In pratica, una fornace che non può essere spenta, nemmeno durante il lockdown che ne ha causato la temporanea chiusura (ancora adesso). Dall’8 marzo lo staff è in telelavoro, ma i pesci devono pur sempre essere nutriti e gestiti. Così, le mansioni dei tecnici che richiedono la presenza sul posto sono state compresse su tre giorni alternati a settimana e sono sovrintese da uno strumento nuovo. «La chat I nostri pesci dell’Acquario», ci dice Paola. «Ci siamo io, Matteo, Alessandro, l’ex direttore Roberto Barbuti, il veterinario Marco Salvadori e la dottoressa Francesca Susini del Laboratorio di Ittiologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pisa».
A prescindere da quarantene, lockdown e tempi normali, fra i compiti dei due manutentori ci sono la verifica della buona salute dei pesci, il funzionamento delle luci e dei filtri, il loro lavaggio e la pulizia delle vasche. Per quanto riguarda il cambio dell’acqua, mi spiegano che c’è un sistema automatico con un timer che scatta quattro volte al giorno. I filtri, che si trovano in un’area a sé, sono collegati alle vasche tramite tubi e vengono puliti con un sistema meccanico. Poi, chiaramente, bisogna dare da mangiare ai pesci. «Normalmente non tutti mangiano tutti i giorni, però ogni giorno c’è qualcuno che mangia», chiarisce Matteo. «Se si sovralimenta il pesce, oltre ad avere un pesce grasso si sporca l’acqua, il che non gli fa bene, ma dato che adesso mangiano tutti in modo più dilazionato abbiamo ridotto i rifiuti. Ho solo i piranha un po’ tristi perché non gli butto più i bambini…». Ride, e in effetti l’idea di avere a che fare coi piranha non mi sembra molto allettante. «Ma no, sono meno aggressivi di quel che si pensa: non è che cali la mano e arrivano. Capiscono quando è ora di mangiare e reagiscono alla vista del ciotolino del mangime: lì arrivano, ma in modo pacato. Sono in una grossa vasca dove per la pulizia bisogna essere in due. Si accede con la scala, una volta sopra non vedi le macchie sul vetro quindi serve l’altro collega che ti dice dove pulire e tiene d’occhio anche i pesci. Ma i piranha, appena vedono la spatola che entra in acqua, si rimpiattano in un angolo».


Ripenso a Semola il luccio. Se è un pacioccone che mangia tranquillo e si lascia pulire la vasca, deve pur esserci qualche specie più “agitata” di lui (e, a quanto pare, anche dei piranha). «Il pesce gatto. Che sia di due centimetri o di un metro, è una fogna», continua Matteo. «Uno dei nostri, Baffo Moretti, quando gli dai da mangiare ti chiappa le mani. Non fa male, il problema è se piglia il guanto e se lo ingoia. Poi c’è il ciclide giaguaro e già il nome te la dice tutta: ha sia le macchie sia il caratteraccio, va tenuto in vasca da solo. Certi pesci son dei personaggi… il pesce palla viene al vetro scodinzolando e agitando le braccine: non nuota con la coda ma coi pettorali, tipo battito d’ali, è una cosa buffissima. E poi ci sono quelli che ti vengono incontro e ti legnano!». Paola Nicolosi spiega che è nella natura delle specie più territoriali: la vasca è la loro casa, così mordono la spugna e il tubo della pompetta come se fossero pericolosi invasori. «Mi ritengo fortunato perché per ora sono stato morso solo da un discus, noto come uno dei pesci più delicati e pacifici nel mondo dell’acquariofilia! Ma anche le tartarughe, per dire, sono tutt’altro che amichevoli». Continua Matteo, e scopro che anche loro hanno un nome: due si chiamano Piggy, essendo della specie naso di porcello, mentre un’altra si chiama Molly perché ha il guscio molle. Molly è un maschio, ma pazienza: ormai il nome è quello.

La socialità degli abitanti dell’Acquario, quindi, è relativa: sia fra di loro, sia verso gli umani. Sono pesci abituati alla presenza dei visitatori, ma durante questo periodo senza pubblico la maggior parte non ha cambiato le proprie abitudini. Tranne due. «I coltello trombetta», dice senza esitazione Matteo, che li conosce uno per uno. «Da quando non c’è nessuno sono contenti e vanno a giro per la vasca. Sono parenti dell’anguilla elettrica, però non stecchiscono la gente con la scossa. C’è anche da dire che gli ho cambiato l’arredamento, gli ho messo più ripari, le piantine… sono un po’ paurosi, hanno paura soprattutto di Paola». «Quando si muovono sono splendidi», aggiunge lei. «Li abbiamo presi apposta, ma appena passo io si adagiano su un tronco, immobili. La prima volta mi prese un colpo perché sembravano morti!».

A proposito, è difficile stabilire un numero preciso di abitanti nell’Acquario perché i pesci nascono e muoiono, e non solo di vecchiaia. Il regime di igiene è stringente per non portare patogeni nelle vasche o viceversa, tuttavia anche fra i pesci ci sono malattie che possono diventare pandemie. «L’ictioftiriasi: la malattia dei puntini bianchi», dice Matteo, come uno scioglilingua. «Capita quando arrivano pesci nuovi: essendo in un ambiente nuovo si stressano, si debilita il sistema immunitario ed ecco la malattia. È molto contagiosa, bisogna isolare il pesce prima che contagi gli altri e trattarlo con medicinale nel cibo». In pratica, il pesce malato viene messo in quarantena. Paola Nicolosi precisa che l’Acquario ha un piccolo stabulario con vasche per l’isolamento. «Capita che i privati ci donino dei pesci – continua Matteo –, anche loro li teniamo in osservazione in quarantena. Ti devi aspettare di tutto: pesci tenuti in acquari troppo piccoli, sovraffollati, con compagni di vasca aggressivi che li hanno legnati… c’è da controllare che stiano bene e che si abituino al regime del museo».
La domanda, a questo punto, sorge spontanea: durante la nostra quarantena, ci sono stati pesci in quarantena? Certo che sì, ma il motivo è allegro e ci fa scoprire il lato nascosto di Matteo: non solo manutentore, ma anche balia. «Durante la nostra quarantena abbiamo avuto delle nascite. Lo stabulario serve anche a questo: se mettiamo i neonati nelle vasche del museo è facile che il cambio ambientale li stecchisca o che finiscano nel filtro», spiega, ed elenca gli ultimi nati come se fossero i suoi. «Al momento ho attiva una riproduzione di Ancistrus, quei pesci che stanno appesi al vetro con la bocca a ventosa. Siamo alla quarta covata. Sono bellini perché hanno le cure parentali: il maschio fa la guardia alle uova, sventola le pinne per ossigenarle e bada ai piccoli nei primi giorni. Ma il nostro fiore all’occhiello sono gli axolotl, dei salamandroni del Messico che hanno un discreto impatto sul pubblico: chi li vede, o gli fanno schifo o son bellissimi! Al momento ho venti piccoli di tre covate diverse, allevarli è molto complesso e mi son dovuto fermare se no non sappiamo più dove metterli. Non mi aspettavo invece una deposizione di alcuni pesci gatto che ho tenuto in stabulario. Ce li ho portati a titolo personale, li ho presi nel Massaciuccoli con un dubbio sulla specie… perché dire pesce gatto è come dire pappagallo… poi un giorno ho trovato le uova e i piccoli!». E la vita continua, quarantena o no, pandemia o no: una fornace che non può essere spenta. Finché Baffo Moretti assalta i guantoni, i coltello trombetta si prendono gioco del prossimo, il pesce palla scodinzola e l’Ancistrus sventola le sue uova, viene da pensare che forse andrà davvero tutto bene.

Glossario erudito (in ordine di apparizione)
- Semola, il luccio italico (Esox cisalpinus)
- I mansueti piranha “ventre rosso” (Pygocentrus nattereri)
- Baffo Moretti, il pesce gatto dalla coda rossa (Phractocephalus hemioliopterus)
- Il cattivissimo ciclide giaguaro (Parachromis managuensis)
- Il gioioso pesce palla (Tetraodon lineatus)
- L’imprevedibile discus (Symphysodon aequifasciatus)
- Le due tartarughe Piggy (Carettochelys insculpta)
- Molly dal guscio molle (Apalone spinifera)
- Gli impertinenti coltello trombetta (Rhamphichthys rostratus)
- I paterni Ancistrus sp.: si chiamano proprio così. Non sono indicati come una specie esatta perché quelli del mercato acquariofilo sono ibridi di origine sconosciuta. A volte sono noti con il nome comune Pleco dal naso a spazzola. A volte con quello meno appropriato di “pulitori”
- I prolifici axolotl (Ambystoma mexicanum)