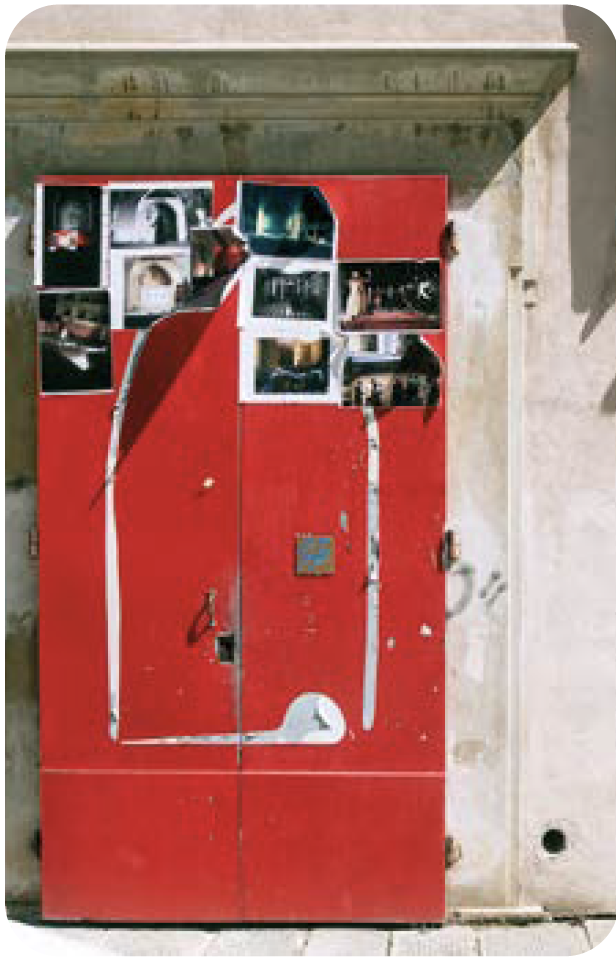Tra il cantiere e il mare c’è di mezzo il mare
Tutti gli ostacoli che i megayacht superano per prendere il mare attraverso il canale dei Navicelli. E se sei pisano e hai un gommone in Arno, puoi davvero andare a Livorno via acque interne?
Lungo il canale dei Navicelli sono presenti 8 darsene di diverse dimensioni e più di 20 aziende produttrici di yacht. Tra queste, una decina realizzano grandi imbarcazioni oltre i 40 metri di lunghezza. Quando le barche sono pronte per essere allestite degli interni presso altri cantieri (spesso nell’area viareggina) è il momento del trasferimento. Le imbarcazioni lasciano il cantiere che le ha costruite e per la prima volta prenderanno il mare. Il passaggio dal cantiere al mare, tuttavia, non è una mera questione di navigazione e richiede il coordinamento di 7 diverse infrastrutture: 4 ponti stradali, 2 ponti ferroviari (uno dei quali militare) e una porta vinciana.
La gestione delle 7 infrastrutture che esistono tra la Darsena Pisana e il mare è affidata a diversi enti e istituzioni. Riguardo al canale dei Navicelli, dopo qualche decennio di gestione da parte della Spa Navicelli di Pisa, di proprietà di Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, la gestione è oggi nelle mani della Port authority di Pisa Srl, società nata nel 2022 con il Comune di Pisa unico socio.
Partendo dalla Darsena Pisana (la più a nord e maggiore tra le darsene del canale), la prima barriera che si incontra è il ponte mobile di Tombolo, un ponte levatoio a doppio raggio costruito lungo via Livornese. Salvo casi eccezionali, questo ponte viene aperto tutti i giorni per tre volte a orari stabiliti. La gestione è della Port authority di Pisa. Poche decine di metri più a sud si incontra il primo ponte ferroviario che è anche quello di più recente costruzione. È un’opera voluta e realizzata dal governo statunitense per collegare la base di Camp Darby alla rete ferroviaria. Il ponte è stato installato nel 2022 ed è ancora in fase di discussione se ne sarà affidata la gestione a Port authority di Pisa o se rimarrà nelle mani dei militari statunitensi. Si tratta di un ponte girevole che lascia spazio alle imbarcazioni in transito ruotando verso un lato del canale. I successivi 6 chilometri sono lisci, un rettilineo largo in media 35 metri e profondo circa 3 permette alle imbarcazioni di raggiungere la fine del canale senza incontrare ulteriori barriere architettoniche. Quando il canale dei Navicelli sfocia nello scolmatore dell’Arno il mare è a meno di 500 metri. Questa via, però, non è un’opzione per le grosse imbarcazioni per via dello scarso fondale alla foce dello scolmatore, incompatibile con il pescaggio dei grossi yacht, e di un’altra barriera architettonica, il ponte del viale del Tirreno, fisso e troppo basso perché le barche grandi ci passino sotto. Si parla da oltre un decennio di sostituirlo con uno mobile e di armare la foce dello scolmatore per permettere l’accesso al mare in sicurezza delle imbarcazioni. Nessun progetto ha però visto la luce. Anzi, è dello scorso marzo la proposta di Port authority di Pisa di sostituire il ponte con un tunnel. Esclusa la possibilità di attraversare la foce dello scolmatore, alle imbarcazioni provenienti dai cantieri pisani non rimane che raggiungere il mare attraverso il bacino principale del porto di Livorno, la Darsena Toscana. Operazione non immediata perché nei 100 metri d’acqua che separano il canale dal porto ci sono ben 5 barriere da superare. La prima è il ponte mobile di Calambrone, anch’esso controllato da Port authority di Pisa con due aperture al giorno, seguita a distanza di pochi metri dalle porte vinciane del porto di Livorno. Le porte vinciane sono uno sbarramento mobile che serve a separare le acque fangose dello scolmatore dai fondali della Darsena Toscana. Sono controllate dall’autorità portuale di Livorno e vengono aperte ogni giorno allo stesso orario del ponte mobile di Calambrone. Superato questo sbarramento mancano ancora un ponte ferroviario (girevole), il ponte stradale mobile di via Mogadiscio e la più inquietante infrastruttura di questa serie, il ponte mobile della Fi-Pi-Li: per permettere alle barche di raggiungere il mare bisogna alzare una superstrada. Oltrepassato il settimo ostacolo, alle imbarcazioni non rimane che attraversare il porto di Livorno e prendere il mar Ligure attraverso l’imboccatura sud del porto lasciandosi a sinistra l’ottocentesca diga della Vegliaia.
Negli anni recenti due nuove infrastrutture, entrambe governate da Port authority di Pisa, si sono aggiunte al meccanismo architettonico del canale dei Navicelli. Si trovano entrambe a nord della Darsena Pisana: il ponte mobile di via II Settembre e l’incile. L’incile è un sistema di chiuse che permette di superare la differenza di quota tra canale dei Navicelli e fiume Arno consentendo così la continuità della navigazione. Viene aperto su richiesta, dal lunedì al venerdì e da aprile a ottobre. Rimane chiuso per il resto dell’anno per via delle piene dell’Arno. È stato inaugurato nel 2019 con una bottiglia di champagne antisfondamento e, ai tempi dell’apertura, il Comune e le istituzioni coinvolte hanno sottolineato quanto l’incile non sia una questione esclusivamente industriale legata alla cantieristica navale. Anzi, l’adagio turistico del “collegare il fosso di Livorno al centro di Pisa” è stato in quelle settimane uno slogan inflazionato. Nel 2021 e nel 2022, Port authority di Pisa ha organizzato delle minicrociere, tra Darsena Pisana e scalo Roncioni sull’Arno passando per l’incile, a bordo di un battello. Non è però chiaro cosa debba fare un cittadino pisano per attraversare l’incile e recarsi a Livorno via acque interne. Così abbiamo provato a seguire le procedure. Il sito di Port authority di Pisa dice che per attraversare l’incile va compilato un modulo. Lo abbiamo fatto, rimanendo però bloccati al primo rigo nel quale il modulo richiede di inserire il “cantiere di arrivo”. Ci è sembrato un modulo relativo all’industria più che al turismo e allora abbiamo contattato via email Port authority di Pisa all’indirizzo segnalato per l’apertura dell’incile: registro@navicelli.it. Dopo 20 giorni di attesa e un sollecito, non avendo ricevuto risposta, ci siamo rivolti al Comune a un altro indirizzo presente nella pagina dell’incile: pm.segreteria@comune.pisa.it. Anche in questo caso, 10 giorni nel momento in cui scriviamo, nessuna risposta. Non ci rimaneva che provare con il caro telefono. La persona che ha risposto allo 050 26158 è stata molto gentile. Ci ha confermato che le imbarcazioni private possono attraversare l’incile gratuitamente. Ha però aggiunto che le procedure potrebbero cambiare e suggerito di richiamare in prossimità della nuova stagione di apertura ad aprile 2024. Non ci è stato chiarito, però, come compilare il modulo non avendo noi un “cantiere di arrivo”, ma volendo usare il nostro gommone di 6 metri per una minicrociera, così abbiamo chiesto, “dal centro di Pisa al fosso di Livorno”.